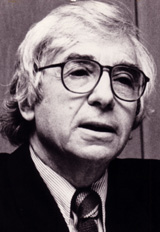
Arno J. Mayer: una “ storia marxista a prospettiva rovesciata, focalizzata cioè sulle classi superiori anziché su quelle inferiori”.
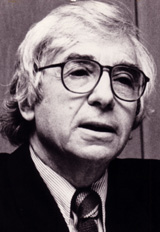
“La Grande Guerra fu un’espressione del declino e della caduta del vecchio ordine che si batteva per prolungare la propria vita, molto più che non dell’ascesa esplosiva di un capitalismo industriale impegnato ad imporre la propria supremazia.”
(Arno J. Mayer, Il potere dell’Ancien Règime fino alla prima guerra mondiale)
In polemica con l’impostazione storiografica tradizionale, lo storico ebraico Arno J. Mayer pubblica, nel 1981, Il potere dell’Ancien Règime, testo nel quale giunge ad una sintesi del suo lavoro di studio sulla società europea di inizio secolo e sulle motivazioni che hanno determinato il germinare in essa della spinta bellica verso il primo (e in seguito il secondo) conflitto mondiale.
“Questo libro vuol essere un contributo alla discussione della causa causans e dell’interna natura del recente “mare di guai” dell’Europa.”
(Crediamo
che, ancora una volta, il modo migliore per illuminare il lavoro dello storico
sia seguire, dispiegare l’intreccio logico del suo discorso usando, quanto più
possibile, le sue stesse parole)
Un “mare di guai” che,
nel lavoro di Mayer, sembra essere, più che “semplicemente” una fase critica
della storia del Novecento (o, meglio ancora, della storia della sua seconda
metà), la definizione
dell’Età contemporanea tutta:
un’età iniziata come “età della catastrofe” - per riprendere una formula usata
spesso da Hobsbawm - e da questa profondamente ed inevitabilmente segnata.
“Malgrado il passare del tempo, la prima metà del Novecento continua ad apparirci come un periodo che ha visto un cataclisma senza precedenti, e che segna uno spartiacque capitale nella storia d’Europa.”
E
“spartiacque” è un’altra formula usata spesso dalla storiografia “classica” per
indicare la prima guerra mondiale, o, in generale, tutto il lungo conflitto
1914-1945.
Eppure, proprio questo termine racchiude l’originalità profonda insita nel
lavoro di Mayer.
“Per troppo tempo, e in grande misura, gli storici [prendendo in esame il periodo d’inizio secolo] si sono concentrati sull’avanzata della scienza e della tecnica, del capitalismo industriale e mondiale, della borghesia e della classe media professionale, della società civile liberale, della società politica democratica e del modernismo culturale. Si sono occupate assai più di queste forze innovatrici, e della formazione della nuova società, che non delle forze dell’inerzia e della resistenza, che hanno rallentato il deperimento del vecchio ordine. Sebbene ad un certo livello gli storici e gli scienziati sociali occidentali abbiano ripudiato l’idea del progresso, ad un altro continuano a credervi, sia pure con alcune restrizioni.
[…] Il risultato è una visione parziale e distorta dell’Ottocento e del primo Novecento. Per raggiungere una prospettiva più equilibrata, gli storici dovranno prendere in esame non soltanto l’alto dramma del mutamento progrediente, ma anche l’inesorabile tragedia della perseveranza storica, ed esplorare l’interazione dialettica tra l’uno e l’altra.”
Questo, Mayer rimprovera a tutti quegli storici che hanno visto nel periodo antecedente la Grande Guerra “il trionfo della borghesia” (si pensi allo stesso Hobsbawm, che proprio così ha intitolato un suo lavoro del 1975): l’aver trascurato nelle loro analisi tutti quegli elementi reazionari, aristocratici, premoderni, persino “feudali” che non solo permanevano nella società di quel periodo ma che ne costituivano ancora l’elemento, forse, più importante.
E proprio dalla presa di coscienza di ciò Mayer fonda una delle premesse a Il potere dell’Ancien Règime.
“La terza e principale premessa di questo libro è che il vecchio ordine europeo era da un capo all’altro preindustiale e preborghese.
[…] la tesi di questo libro è che gli elementi “premoderni” non erano i residui fragili e in dissoluzione di un passato quasi completamente svanito, ma l’essenza medesima delle società civili e politiche d’Europa. Con ciò non si vuol negare la crescente importanza delle forze moderne che minavano e contestavano il vecchio ordine. Ma si vuole sostenere che fino al 1914 le forze dell’inerzia e della resistenza hanno mantenuto e raffrenato questa dinamica e rigogliosa nuova società entro la cornice degli anciens régimes che dominavano il paesaggio storico dell’Europa.”
Ma prima di passare a riassumere brevemente quali elementi possono, secondo Mayer, giustificare questa tesi, ripercorriamo le altre due premesse dalle quali lo storico fa partire la sua analisi.
“Esso muove dalla premessa che la guerra mondiale degli anni 1939-45 è ombelicamente legata alla Grande Guerra combattuta tra il 1914 e il 1918, e che questi due conflitti sono né più né meno che la Guerra dei Trent’anni della crisi generale del Novecento.”
“La seconda premessa è che la Grande Guerra del 1914, ovvero la fase prima e originaria di questa crisi generale, fu il portato di una rimobilitazione, avvenuta di fresco, degli anciens régimes europei. Pur perdendo terreno rispetto al capitalismo industriale, le forze del vecchio ordine erano ancora sufficientemente ostinate e potenti da far resistenza al corso della storia, e rallentarlo, se necessario mediante il ricorso alla violenza. La Grande Guerra fu un’espressione del declino e della caduta del vecchio ordine che si batteva per prolungare la propria vita, molto più che non dell’ascesa esplosiva di un capitalismo industriale impegnato ad imporre la propria supremazia. Nel 1917 in tutta Europa le tensioni provocate dal prolungarsi del conflitto avevano ormai scosso e frantumato le fondamenta del vecchio ordine, che del conflitto era stato l’incubatrice. Eppure, con la sola eccezione della Russia, dove il più rigido il meno ristrutturato dei vecchi regimi crollò, dopo il 1918-19 le forze della persistenza si ripresero a sufficienza da aggravare la crisi generale dell’Europa, patrocinare il fascismo e contribuire al riemergere della guerra totale nel 1939.”
Qualche considerazione. Nel sistema costruito da Mayer, dunque, l’Ancien Régime, che sembrava essersi “dissolto” con l’avanzare dell’età moderna, permane, non solo, come sembra suggerire il titolo della sua opera, fino alla Grande Guerra, ma addirittura nella formazione e nello sviluppo dei fascismi (che nascono proprio con un carattere intrinsecamente antiborghese: un elemento ulteriore a prova della tesi di Mayer).
“I vecchi regimi europei erano società civili e politiche fornite di ben precisi poteri, tradizioni, costumi e convenzioni. E proprio perché costituivano sistemi sociali, economici e culturali così integrati e compatti, essi erano eccezionalmente elastici. Persino in Francia, dove fu dichiarato legalmente defunto tra il 1789 e il 1793, l’ancien régime continuò a raffiorare con violenza, sopravvivendo per molti versi durante oltre un secolo. Naturalmente, l’Europa non era un’entità unitaria. C’erano grandi differenze nazionali e regionali nelle economie, nelle strutture sociali, nelle tradizioni giuridiche e nelle mentalità; e queste singolarità storiche non possono essere né ignorate né minimizzate. Ciò nondimeno, così nella sua fioritura come nel suo tenace prolungarsi nei tempi moderni, l’ancien régime è stato un fenomeno nettamente pan-europeo.”
Inoltre, è interessante notare come quelli che Mayer definisce “attori principali” del conflitto (“statisti-politici e generali”) finiscono, nel quadro che così si delinea, per perdere la connotazione di “meschini improvvisatori”, o “dilettanti romantici” o ancora “avventurieri impazienti” per assumere pienamente una nuova, terribile, identità.
“Le classi superiori d’Europa erano pronte a portare i loro popoli ad una catastrofe dalla quale speravano, contro ogni speranza, di trarre vantaggi per sé. […] Nella marcia verso la soglia del baratro, i politici ed i generali della reazione aristocratica erano certamente più complici che avversari o rivali. […] [E condividevano il] comune impegno a lottare contro la democrazia politica, il livellamento sociale, lo sviluppo industriale ed il modernismo culturale. […] Lungo il cammino, non uno solo tra gli attori principali fu preso dal panico, o fu motivato da anguste preoccupazioni personali, burocratiche o di partito. […] tutti erano egualmente decisi a conservare, o riconquistare, un idealizzato mondo di ieri.”
Torniamo quindi a quella che lo stesso Mayer definisce la tesi principale de Il potere dell’Ancien Règime.
A conferma del carattere marxista che egli attribuisce alla sua analisi, il punto d’avvio di quest’ultima è proprio l’aspetto economico della società pre-1914.
“La società civile del vecchio ordine era innanzitutto e soprattutto un’economia contadina ed una società rurale dominate da nobiltà ereditarie e privilegiate. Eccettuati pochi banchieri, mercanti e armatori, le grosse fortune e i grossi redditi avevano la loro base nella terra. […] La terra restò fino al 1914 la forma principale di ricchezza e di reddito delle classi dominanti e di governo. […] In tutta Europa, i settori manifatturiero e commerciale delle economie nazionali erano dominati da imprese di piccole e medie dimensioni a proprietà, finanziamento e gestione familiari. Questo capitalismo imprenditoriale generò una borghesia che era, nel caso migliore, protonazionale. In quanto classe, tale borghesia aveva interessi economici comuni, ma la sua coesione sociale e politica era limitata. Questa borghesia manifatturiera e mercantile non poteva gareggiare con la nobiltà terriera quanto a identità di classe, status o potere.”
Solo in seguito, e solo in considerazione di quest’aspetto, Mayer passa ad analizzare le sovrastrutture politiche, sociali, culturali di questa difficile realtà.
“In tutta Europa le nobiltà terriere occupavano il primo posto in campo non soltanto economico, sociale e culturale, ma anche politico.
In effetti, la società politica era il perno di
questa società d’ordini agraria. Essa assunse ovunque la forma di sistemi
d’autorità assolutistici, in diverso grado illuminati, e capeggiati da monarchi
ereditari. Le corone regnavano e governavano
con l’appoggio di vaste famiglie reali e di partiti della corte, ma anche di
ministri, generali e burocrati arrendevoli.”
“L’intero regime era permeato
dal
retaggio del feudalesimo,
malgrado lo si presumesse esaurito con il Medioevo. […] Nello stretto intreccio
di potere politico, giuridico e militare [dell’autorità monarchica] da un lato,
e di proprietà terriera dall’altro, quello declinò molto più rapidamente e
massicciamente di questa. Il perdurante sistema signorile lasciò un’impronta
profonda sul vecchio regime, perpetuando la figura del nobile privilegiato che
esaltava, arrogandoseli, l'ethos della fedeltà personale, l'esercizio della
virtù marziali ed il dovere del servizio pubblico.
[…] Inoltre, nel mentre che elaborava un modus vivendi con la corona, la nobiltà di spada infondeva i suoi antichi valori nell’intera sfera della nobiltà di servizio, così civile come militare. Di fatto, gli stessi re s’imbevvero di quest’orgoglio nobiliare. Convinti che i loro troni fossero legati alla struttura gerarchica della società d’ordini, sostennero tale società civile sia economicamente che socialmente.
Contemporaneamente, pur privandoli della loro
autorità sovrana in campo politico e militare, i monarchi assoluti assorbirono
nobili e signori nel loro apparato statale.
[…]E’ dunque chiaro che il feudalesimo dotò il vecchio ordine europeo di molto più che un mero tegumento di tradizioni, costumi e mentalità propri delle classi superiori. Esso compenetrò gli anciens régimes attraverso ceti nobiliari la cui collocazione li metteva in grado di monopolizzare le leve strategiche in campo così economico come militare, così burocratico come culturale.”
“Se gli elementi feudali presenti nella società sia
politica che civile perpetuarono con tanta efficacia il loro dominio, ciò si
dovette in buona parte al fatto che seppero adattarsi e rinnovarsi. Le nobiltà
di servizio, sia civili che militari, assorbirono ambiziosi rampolli,
accuratamente selezionati, dei ceti imprenditoriali e delle professioni
liberali, badando allo stesso tempo a regolare attentamente questo afflusso di
sangue nuovo e di nuove capacità.
[…] le vecchie élites eccelsero nell’assorbire selettivamente, nell’adattare e
nell’assimilare le nuove idee e pratiche senza compromettere seriamente il loro
status, il loro temperamento e la loro mentalità tradizionali.”
“Le mentalità delle élites europee restavano probabilmente ancor più indietro, rispetto agli sviluppi economici, che non la loro vita sociale e culturale. In ogni caso, il loro orizzonte mentale mutò molto lentamente, e costituisce il sintomo forse più rilevatore del loro perdurante radicamento nel –e fedeltà al- vecchio regime. Le classi di governo, nelle quali l’elemento feudale rimaneva particolarmente rilevante, erano interamente imbevute di valori e atteggiamenti nobiliari. La loro visione del mondo era consentanea ad una società gerarchica, fondata sul comando, piuttosto che ad una società liberale e democratica”
Questo è, in sintesi, il quadro nel quale Mayer inserisce quella che lui chiama la “Guerra dei Trent’anni del Novecento”.
Concludiamo con un’ultima
osservazione, sull’originalità dell’operazione compiuta da Mayer e sui suoi
effetti (diretti o meno) sulla recente storiografia. Infatti, se il lavoro di
Mayer poteva forse sembrare all’inizio degli anni Ottanta quantomeno “audace”
nel suo spostare così in avanti il “trionfo della borghesia”, e con esso
l’inizio dell’Età contemporanea, ora sono molti gli storici che tendono a vedere
il XIX secolo sempre meno legato all’Età contemporanea e sempre più come una
fase di transizione, limitando l’analisi della Storia contemporanea al solo XX
secolo, oppure, in alcuni casi, a una sola parte di esso (si veda ad esempio
Barraclough, che sposta l’inizio del XX secolo agli anni ’60, o Milward, che
arriva persino al 1974).
Un’originalità, inoltre, che lo lega, o meglio, lo avvicina profondamente
all’ultimo storico che considereremo in questo lavoro, Ernst Nolte: non tanto
per l’interpretazione dei fenomeni storici che hanno portato alla Guerra dei
Trent’anni (che sono, invece, nei due storici, diametralmente opposte) quanto
per la comune operazione di spostamento della tradizionale “prospettiva storica”
a favore di nuove, anche se non sempre corrette sicuramente interessanti,
narrazioni storiche.