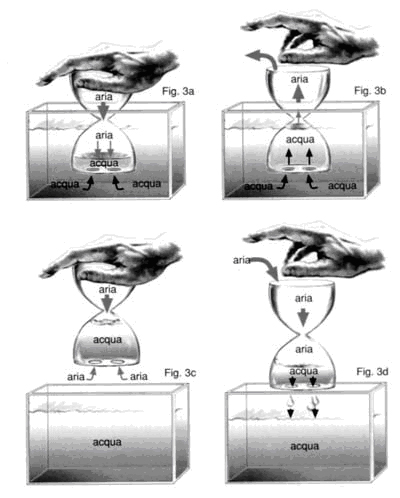|
Nell’indagini di fisiologia contenute nel Poema
Fisico Empedocle si sofferma sui meccanismi della respirazione che
avviene tramite i pori della pelle e che è prodotta dalla pressione
alternata dell’aria e del sangue dentro i vasi capillari che
percorrono l’intero organismo. Quando il livello del sangue scende,
nei vasi capillari può entrare dai pori l’aria e si ha
l’inspirazione; quando il livello del sangue torna a salire, l’aria
viene espulsa dai pori e si ha l’espirazione. Questo processo viene
illustrato con l’esperimento della clessidra immersa in un
recipiente d’acqua. Come l’acqua del recipiente entra ed esce nella
clessidra a seconda della maggiore o minore pressione dell’aria,
così nelle vene il sangue avanza o retrocede in rapporto alla
pressione dell’aria. Più esattamente, data una clessidra vuota con
le parti superiore ed inferiore forate, qualora venga immersa in
acqua ed i fori superiori siano otturati da una mano, l’aria
imprigionata nella clessidra impedirà all’acqua di entrare; se si
toglie la mano entrerà dai fori sottostanti tanta acqua quanta è
l’aria che esce; se si toglie la clessidra dalla vaschetta tenendo i
fori superiori otturati, la pressione dell’aria sui fori inferiori
impedirà all’acqua di uscire; lasciando liberi i fori superiori,
entrerà l’aria che spingerà fuori dai fori inferiori una quantità
corrispondente d’acqua.
La prova della clessidra non costituisce una
sperimentazione vera e propria, ma è una verifica costruita per
analogia: essa permette di capire quanto non è osservabile dentro il
corpo umano, prestando attenzione a quanto accade di simile
all’esterno nel mondo fisico. In virtù infatti, del principio
conoscitivo di Empedocle secondo cui “il simile è conosciuto dal
simile”, si può spiegare ciò che accade nei vasi capillari tra aria
e sangue osservando il rapporto tra aria ed acqua all’esterno del
corpo. |